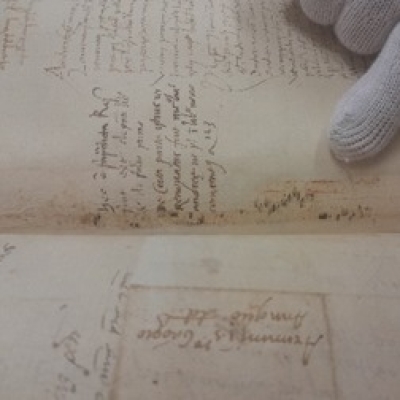Non si sa perché, a un certo punto – o meglio sappiamo benissimo perché – la festa di Ognissanti, legata al Giorno dei Morti, è stata sostituita da Halloween, la trasformazione molto americana di Samhain. In Irlanda Samhain assomigliava moltissimo alla nostra percezione antica della notte miracolosa dove l’aldilà si apre per comunicare con noi. Loro tornavano. Lo scambio era intenso, un rovesciamento di stagioni dell’anno, un rapporto d’amore, una lotta, una tensione che si riapriva. Se in quella notte sospesa - «La notte», sussurra Fellini, «è l’arresto definitivo delle inquietudini della vita. Immagino simile in qualche modo la morte, con le stelle, gli alberi, la luna sempre piena e case abitate da fantasmi discreti…» - se in quella notte mistica, non sentiamo che esistono le presenze del divino o del sacro, che la comunità dei vivi e dei morti è sostanziale, ci priviamo della sensibilità che alimenta la bellezza.
Poeta tra i più grandi, e irlandese, Yeats veniva accusato di credulità quando scriveva che «gli esseri divini sicuramente esistono: solo noi che non possediamo né semplicità né saggezza li abbiamo negati, mentre i semplici di ogni epoca e i saggi del tempo antico li hanno visti e con loro hanno persino parlato. Essi sopravvivono alla loro vita appassionata [...] noi stessi saremo tra loro quando morremo, se soltanto riusciremo a mantenere la nostra natura semplice e appassionata. Non potrà forse accadere che soltanto la morte ci unisca al mondo immaginale?».
Anche le nostre tradizioni, penso particolarmente a quelle di Romagna, tendevano a fondere i mondi: quello immaginale, con il mondo dei morti, ultraterreno. Più di tutti Pascoli. La sua ossessione, per le morti del padre ucciso, della madre, dei fratelli che lo seguono, è così assoluta da costituire il cibo del dolore e la salvezza, l’eucaristia principale della poesia.
La prima delle Myricae, La notte dei morti (1891) annuncia la visione dei propri cari: «Io vedo (come è questo giorno, oscuro!),/ vedo nel cuore, vedo un camposanto/ con un fosco cipresso alto sul muro.» Ne La tovaglia, nei Canti di Castelvecchio (1903), la bambina che è Mariù, sparecchia a sera la tavola, ma lascia la tovaglia, un invito a un’agape silenziosa e notturna, che somiglia all’offerta del sangue nell’Ade per l’incontro di Ulisse con Tiresia, ma soprattutto con la madre morta (Odissea XI), o per quello di Enea con il padre Anchise, tre volte invano abbracciati a braccia vuote (Eneide VI): «lascia che vengano i morti/ i buoni, i poveri morti». In Giovannino, in Ritorno a San Mauro (1907), lo sguardo va ai fanciulli dietro alla porta lontana: «addormentati in mezzo ai lor trastulli;/ s’apre appena e si chiude e par che tremi;/ assai se, là, venir tra i crisantemi/ vedo la rossa veste di Gesù!...». Nella mirabile prefazione alle Myricae invoca i canti degli uccelli, che nidifichino almeno sulla tomba della madre, poiché «la crudele stupidità degli uomini li ha ormai aboliti dalle campagne» e i suoni delle campane suonano non solo a gioia o a messa, ma «specialmente a morto». Domanda se sono troppi gli uccelli, se è troppa questa morte e si risponde: «Ma la vita, senza il pensier della morte, senza, cioè, religione, senza quello che ci distingue dalle bestie, è un delirio, o intermittente o continuo, o stolido o tragico.». La sua poesia è nata dalla campagna, dove «non c’è visione che più campeggi [...] che quella dei trasporti o delle comunioni che passano: e non c’è suono che più si distingua [...] che quello delle Avemarie.». Alla madre contemplativa deve la sua poesia. Non ha mai accettato la morte ingiusta di un padre «innocente e virtuoso, sublime di lealtà e bontà», cui segue quella della famiglia: «Io non voglio che sian morti». La sua poesia è nata anche per ispirare «un più acuto ribrezzo del male». Se vi riuscisse, «ne benedirei la memoria de’ miei cari martiri [...] che dalla loro fossa rendono anche oggi, per male, bene.».
L’agiografia familiare di Pascoli si fissa in quel preciso punto in cui la mente greca e latina, con la celtica, è assorbita dal cristianesimo: quella certezza di anime tenute serrate da un padrone degli inferi, che sulla terra assomigliano a uccelli gioiosi, nutriti dal Padre celeste (Mt, 6,10), cadono come foglie (Omero, Mimnermo, Virgilio), e sono liberate da Gesù, il Cristo che vi discende, si fa primo dei morti, risorge: «tra i crisantemi/ vedo la rossa veste di Gesù!». È la liberazione dei “martiri”. Ma un altro mito si sovrappone all’antico. Esiodo nelle Opere e i giorni racconta le fasi dell’umanità: iniziano ai tempi di Crono con gli uomini beati dell’età dell’oro, che non conoscono mali, e che Zeus estingue, trasformandoli in dèmoni benevoli. Custodi degli uomini che hanno cura della giustizia, donano la ricchezza, sono una sorta di santi protettori, come i morti dai quali viene il bene. Un insopprimibile bisogno di bene, di custodia della felicità provata come anteriore, necessaria alla fine, grida contro il male: «Io non voglio che sian morti». Si traduce nel martirio, nel sacrificio per il bene, che genera i santi. I nostri custodi. I nostri genitori, i nostri fratelli che guidano alla morte santificata che ci attende.
Questa mirabile drammaturgia dell’anima cosmica nel viaggio delle anime, che noi siamo, si è trasformata nella scenografia dei travestimenti da carnevale zombie di Halloween, una delle metamorfosi del nostro tempo. Tra le contaminazioni della tradizione, che Zolla ora condannava, ora smascherava senza condannarle, come un gioco di sogni.
Nel Crepuscolo celtico, dove raccoglie semplici storie di contadini che ragionano come Omero, Yeats parla di quella soglia che si spalanca. C’è «una guerra tra i vivi e i morti, e le storie irlandesi insistono su ciò. Esse sostengono che quando le patate o il grano o ogni altro frutto della terra marcisce, essi maturano nel Regno fatato, e che i nostri sogni perdono la loro saggezza quando negli alberi monta la linfa, che gli stessi nostri sogni possono far seccare gli alberi, che a novembre si odono i belati degli agnelli del Regno fatato, e che occhi ciechi possono vedere più degli altri». «Cos’altro può mai essere la morte, se non l’inizio della saggezza, del potere e della bellezza?»
La religione dei Gaeli identificava le proprie origini da Magh Môr, la «Grande Pianura», che era sia luogo dei morti, sia Terra dell’eterna Giovinezza. Tutto partiva da un’idea potentissima della morte, che non è fine ma inizio, come nell’antichissima Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, che apre davanti a noi la fisica, per noi ancora misteriosa, dell’universo.
Rosita Copioli