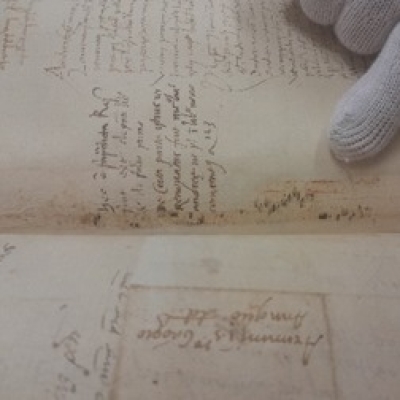Case, laboratori di restauro, scuole, fattorie. Perfino una pizzeria. Il regista e attore forlivese porta le ‘Memorie di Adriano’ della Yourcenar nei luoghi dove il pubblico si può “compromettere” senza schermi.
Se la vorrebbe tatuare quella frase dell’imperatore Adriano, ma non ne ha ancora trovato il coraggio, confida Franco Palmieri dopo la quarantaduesima replica del suo Sufficit, monologo di 53 minuti tratto dal capolavoro di Marguerite Yourcenar ‘Memorie di Adriano’. Non se l’è ancora scritta sulla pelle, ma di certo se l’è impressa nell’anima e a modo suo ne sta proseguendo la strada. “Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo”, racconta di sé l’imperatore sessantenne malato, nelle sue lettere. E responsabile davanti alla bellezza della parola e del teatro si sente l’attore regista forlivese, allievo di Giovanni Testori.
Palmieri ha scelto la forma del teatro d’appartamento per portare in scena il suo Adriano. Non solo case o giardini per la verità, tra i luoghi che hanno ospitato le quarantadue repliche del suo Sufficit (in italiano ‘Basta’), si annoverano anche un laboratorio di restauro a Roma, una scuola in Romania, una fattoria a Bologna. Perfino una pizzeria a Rovigo e un agriturismo a Pisa. Fino all’ultimo appuntamento, in ordine di tempo, domenica scorsa in un appartamento a Rimini. Una forma che ricorda il teatro clandestino di un certo Karol Wojtyla, che amava dire che per fare teatro basta un testo, un attore e una candela. Anzi, della candela si può anche fare a meno.
Perché hai scelto il teatro d’appartamento?
“Perché l’appartamento stabilisce un rapporto di corresponsabilità rispetto alla parola, che nel teatro normalmente inteso è difficile ottenere. Mentre a teatro si guarda, in un appartamento si partecipa. Lo spettatore rompe la finzione e la parete di separazione. È un po’ come se entrasse nello schermo. Shakespeare, fa dire ad Amleto, all’inizio dell’opera: ‘Chi è là?’. È una battuta illuminante, che segna tutto il teatro e per chi fa questo mestiere è enigmatica, segna un qui e un là. Il teatro è un qui. Il teatro d’appartamento è una forma estrema di rottura di questa separazione”.
Ti sono anche arrivate offerte per portare quest’opera in teatri importanti, perché le hai rifiutate?
“Perché questo lavoro mi è accaduto, non l’ho cercato. Mi è accaduto a una certa età, in una determinata situazione personale, in un punto importante della mia vita. Mi ha incontrato, ecco. Una sera, distrattamente, ho iniziato a leggere questo libro, (‘Le memorie di Adriano’ di Marguerite Yourcenar, ndr). Non avevo nessuna voglia di metterlo in scena, tantomeno di mettermi a fare teatro d’appartamento! Avevo già chiuso col teatro”.
Cos’è che ti ha fatto cambiare idea?
“È accaduto che questo testo mi ha chiamato. Come il Robert De Niro di ‘Mission’ quando gli chiedono: ‘Chi sei?’ E lui risponde: ‘Uno che è stato chiamato’. È quello che mi è successo e continua a succedermi, anche dopo la serata di ieri. Mi accompagna questo sentimento di fare qualcosa che mi è stato chiesto e che voglio restituire in questa forma compromettente”.
In che senso compromettente?
“Perché queste venti persone sono lì con me, compromesse con questo avvenimento che in me nasce dal rapporto con Adriano e la Yourcenar. Altra cosa è quando produci uno spettacolo e lo vendi. Ho voluto tenere fuori questo lavoro dalla catena di produzione, distribuzione, vendita”.
Eppure con quella di ieri sera sei già a quarantadue repliche…
“E arriverò a 50 entro la fine dell’anno! Senza pubblicità o notizie – questa è la seconda intervista in due anni –. C’è come un’onda che cresce, che si fonda solo sul passaparola”.
Cosa significa che questo testo ti ha chiamato?
“Ci sono due motivi enormi che mi hanno inchiodato al divano, dove sono seduto anche in questo momento. Il primo è la sublimità delle parole. Noi oggi siamo abituati a parole meno che quotidiane, quasi banali, funzionali, tecniche. Il nostro è un parlare più che primitivo, decaduto. Appena ho iniziato queste pagine mi sono trovato invece davanti a una persona che usa la parola come oggetto divino. Che nasce dall’anima di chi scrive, non dalla tecnica o dal vocabolario”.
Il secondo motivo?
“È la personalità di Adriano. Io non sapevo quasi nulla di lui prima di leggere il libro della Yourcenar, se non che fosse un imperatore e tanto mi bastava. Ma c’è quella frase che mi ha letteralmente aperto il cuore: ‘È difficile rimanere imperatore in presenza di un medico’. Mi ha letteralmente schiantato, perché dice in termini semplici quant’è difficile essere uomo davanti al proprio limite. E di fronte alla morte, che è il limite del limite. Che un imperatore avesse la ‘sperdutezza’ del limite, di cui parlava Testori, mi ha conquistato. Un altro aspetto è la fluidità della lingua della Yourcenar, che rende l’opera teatrabile. Non tutte le penne e non tutti i libri lo sono, questo sì”.
A proposito di teatrabilità. Tu in questo lavoro sei sia protagonista e unico attore, che regista. C’è una scenografia, per forza di cose semplice, ma con una cura di particolari che aiutano ad entrare nell’opera, come il bastone, il coltello o la barchetta-giocattolo di legno. Ci racconti come sono emersi alcuni di questi particolari – non vogliamo rivelare tutto, però! – in questi due anni di repliche?
“Mi sono reso conto, in quest’ultimo lavoro, di quanto il tempo sia l’elemento più indiscutibilmente utile per creare. Perché ti permette di scartare il superfluo e di correggerti. In pratica ti dà la possibilità di sbagliare”.
Puoi raccontarci alcuni di questi sbagli?
“I primi tempi, ad esempio, uno dei pensieri fissi che avevo era che il pubblico dovesse percepire subito che si trattava di un corpo malato, non di una notizia di malattia. E mi sono aggrappato a una serie di idee, come il portaflebo, la carrozzina e altri particolari. Ho creato una partitura legata a gesti che poi risultavano barocchi, non necessari. Per giungere alla semplicità di adesso c’è stato un lavoro lungo. Perché succede come quando ti vengono gli ospiti a casa, all’inizio prepareresti un sacco di cose da mangiare, di dolci in più, invece poi è la semplicità che ripaga. Ma la semplicità non è un niente di partenza, ma è l’esito di un lavoro. Quando ho iniziato a pensare allo spettacolo ero uscito da poco dall’ospedale, ma pian piano dell’ospedale è rimasto solo l’elemento dell’acqua, che rappresenta un’esigenza fondamentale per chi sta male. E Adriano, secondo la Yourcenar, aveva un rapporto divino con l’acqua, che è la fonte principale della vita. Quindi in scena sono rimaste questa brocca e questo bicchiere d’acqua”.
E poi c’è la ‘piccola barca’.
“Sì, le uniche due parole che aggiungo, rispetto al testo originale, sono proprio queste: ‘piccola barca’. Vengono da un dialogo con un mio nipotino, al quale avevo insegnato a fare una barchetta. Gli ho detto: ‘Guarda, nonno t’insegna a fare una barchetta!’. Lui mi ha risposto: ‘La so già fare, e poi nonno non si dice barchetta, ma piccola barca’. Il giorno dopo, davanti a una frase della Yourcenar che descriveva un viaggiatore che naviga, mi è venuta in mente la piccola barca e l’ho aggiunta, sia al testo che agli oggetti in scena. L’idea della corona invece me l’ha data mio figlio, originariamente era una cintura. È così, se sei alla ricerca di qualcosa, e ti dai del tempo, la realtà ti parla”.
Dicevi anche che è un testo molto attuale, perché?
“È un libro sulla sofferenza, sul dolore di vivere. Oggi il dolore, la morte, sono il fattore più censurato, dopo Dio. L’altro aspetto è la totale lontananza da Dio. È un testo non cristiano e forse neppure religioso, ma che mette al centro proprio questa nostalgia di un divino che sia presente. E questo, secondo me, è notevole, perché la Yourcenar non si dichiara neanche credente, come non lo è mai stato Adriano. E anche questo è un paradosso enorme, perché ha un rapporto divino con tutto. Mi piacciono molto, ad esempio, i brani sul cibo, quei pesci insaporiti da un granello di sabbia che scricchiola sotto i denti. Mi ricorda una frase di Joseph Ratzinger: ‘Anche chi non riesce a credere, dovrebbe comunque vivere come se Dio esistesse’. Il tempo di Adriano e quello tra Cicerone e Marco Aurelio, è un tempo in cui non ci sono più gli dei e Cristo non è ancora presente. Dove l’uomo, forse per la prima volta nella storia, è solo. Ecco, l’uomo senza Dio è disperatamente solo. Questo mi commuove ogni volta che metto in scena quest’opera”.
A cura di Alessandro Caprio